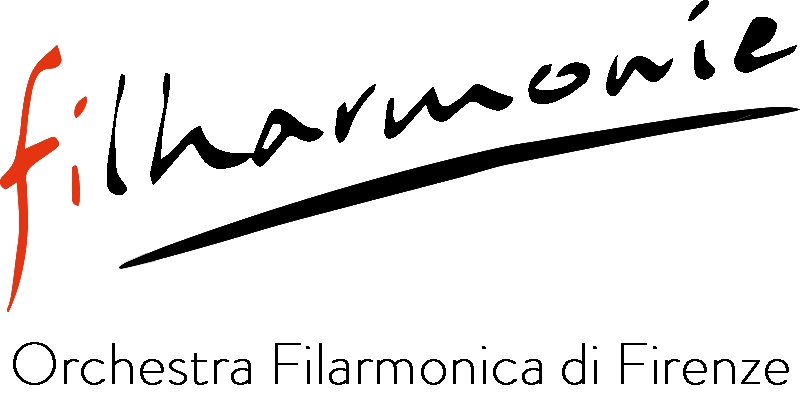Il Peer Gynt di Ibsen/Grieg
di Felicita Pacini

Il Peer Gynt di Ibsen/Grieg
di Felicita Pacini

Scritto tra Roma, Ischia e Sorrento, il Peer Gynt di Ibsen è l’opera più centrale e identificativa della Norvegia, al pari di Don Chisciotte in Spagna o del Faust in Germania. Fu pubblicato nel 1867 quando Henrick Ibsen (1828-1906) si trovava in Italia già da tre anni e sarebbe rimasto lontano dalla sua patria, la Norvegia appunto, per altri ventisette. Il motivo del suo espatrio è dovuto principalmente all’esigenza di scoprire nuovi orizzonti in seguito alla delusione per la mancanza di solidarietà da parte dei Paesi scandinavi nei confronti della Danimarca, lasciata sola nella guerra di Schleswig-Holstein contro il nemico tedesco del 1864. Una modesta borsa di studio governativa rappresentò per Ibsen l’occasione di trasferirsi a Roma dove, ottenuto il primo successo editoriale con il dramma Brand, cominciò la stesura del Peer Gynt. Questo dramma da leggere (læsedrama), scritto in versi, così come era stato pensato in un primo momento, è un’opera di importanza centrale nella produzione di Ibsen sia perché sta al confine tra il primo periodo “romantico” e il successivo periodo cosiddetto borghese (caratterizzato dai grandi drammi quali Spettri, Una casa di bambola etc.) sia perché pone in evidenza il problema di fondo dell’opera dell’autore norvegese, cioè l’intrigante rapporto tra l’essere uomo e l’inclinazione a diventare un troll, ovvero a vivere un’esistenza impoverita, grottesca, tendente ad ogni compromesso e irrealizzata.
Dal gennaio del 1874 Ibsen cominciò a premere perché l’opera venisse messa in scena e prese contatti sia con il compositore connazionale Edvard Grieg sia con il direttore del Christiania Teater, lo svedese Ludvig Josephson. L’Autore riteneva che la formula di rappresentazione più adeguata potesse essere quella del musikalsk drama ovvero di un allestimento ridotto del copione «accompagnato da buona musica». È probabile che l’ispirazione per questa decisione provenisse dalla visione da parte di Ibsen della versione melodrammatica del Faust di Gounod, rappresentata da una compagnia italiana nel 1869 a Christiania. Sebbene Grieg si fosse mostrato restio nell’accettare l’incarico considerando il Peer Gynt come «il meno musicale di tutti i soggetti», da tale connubio artistico nacque un’opera destinata a riscuotere un enorme successo e a rimanere viva nei secoli successivi.
Secondo lo studioso Franco Perrelli, il primo allestimento di Peer Gynt, il 24 febbraio 1876 al Christiania Teater, si presentò come un magistrale saggio di protoregia e probabilmente una delle messe in scena più importanti del secondo Ottocento. La musica di scena per soli, coro e orchestra, per il poema drammatico Peer Gynt op. 23 comprende ventisei numeri musicali che portarono la durata dello spettacolo a un totale di cinque ore con trenta cambi di scena. Come ha scritto lo storico e critico letterario Ivo de Figueiredo, dopo una prima contrasta accoglienza in cui l’opera apparve una satira norvegese, si è voluto in seguito vedervi un dramma di avventure, il cui protagonista «percorre una fantastica odissea attraverso la vita per conquistare infine principessa e regno nella capanna di Solvejg».
Proprio per l’impegno e la dispendiosità che richiede tale allestimento teatrale e musicale insieme, oggi, nelle sale da concerto, è più facile poter assistere all’esecuzione delle due suites orchestrali op. 46 e 55 che raccolgono i brani più amati e popolari della più desueta op. 23. Di seguito, alcuni di questi per tentare di metterne in risalto le caratteristiche.
Iniziamo dal brano forse più noto: Il mattino. Si tratta di un Allegro pastorale in 6/8 che, nella partitura originale op.23, apre il IV atto nel momento in cui Peer, durante le sue peregrinazioni in giro per il mondo alla ricerca di se stesso, si trova nel deserto del Marocco e intagliando una canna a mo’ di zufolo pensa fra sé: «Che deliziosa mattinata! Le sue palline sulla ghiaia lo scarabeo rotola; dal guscio la lumaca striscia. Il mattino; sì, ha l’oro in bocca. È comunque un singolar potere, quel che alla diurna luce conferito ha la natura. Così sicuri ci si sente, crescer il coraggio si sente, capaci si sarebbe, se il caso, con un toro di attaccar briga!». Impossibile non sentir riecheggiare queste parole anche nella musica di Grieg, che inizia con una melodia sommessa affidata al flauto a cui fa subito eco l’oboe in un dialogo ai primi albori del sole mentre cresce l’intensità fino alla metà del brano, quando si ripresenta la melodia iniziale nel forte degli archi insieme a un tutti orchestrale a significare quel singolar poter del sole che splende in alto. Raggiunto l’apice, avviene come un ritorno verso il punto di partenza: dal tutti orchestrale si torna dolcemente a distinguere il timbro di alcuni strumenti, il corno, l’oboe, il flauto e i violini con cui si chiude questa incantevole cornice paesaggistica.
La morte di Aase è un brano di tutt’altro carattere; lo stesso Ibsen scriveva a Grieg di immaginare questa musica come «un accompagnamento in sordina» alla scena che descrive la morte della madre di Peer. Seguendo questa indicazione, l’orchestra di soli archi suona un Andante doloroso in 4/4 che ci trascina dentro un’atmosfera struggente, data dalla tonalità minore e dall’incedere ritmico lento e regolare frammezzato da scale cromatiche che non hanno la forza per slanciarsi e sono costrette a ripiegarsi su se stesse.
Il terzo brano che presentiamo, con quell’incipit inconfondibile dei fagotti, è forse il più conosciuto delle suites: Nell’antro del re della montagna. Qui la musica di Grieg ha a che fare con l’evocazione delle creature fantastiche tipiche delle fiabe norvegesi. Siamo nel II atto e Peer si trova dentro la montagna, nel salone reale del Vecchio di Dovre, re dei troll, dove si stanno riunendo tutti i troll di corte, gli gnomi, i coboldi e i parenti del re che, incuriositi dalla strana presenza di quell’essere umano, si trovano in grande agitazione. Il protagonista di questo brano è il fagotto che, sul pizzicato degli archi, apre il brano eseguendo in pianissimo due semiminime staccate con tempo Alla marcia e molto marcato, proprio come se volesse richiamare l’avanzare goffo e un po’ scomposto di un troll. Ad un certo punto, mentre il ritmo incalza verso un crescendo inevitabile, entrano gli archi che ripetono i passi del fagotto in pizzicato dando l’idea del sopraggiungere di creature più minute e leggere. Il crescendo sempre più forte, la presenza di tutta l’orchestra e l’incedere del ritmo sempre più veloce danno l’effetto di trovarsi ora davanti agli occhi una folla scalpitante di strane creature arrivate da lontano. Nella stretta finale una serie di fulminee pause delimitate dalla percussione dei piatti richiamano il silenzio nel salone e l’entrata maestosa del re della montagna.
L’ultimo brano che vorrei presentarvi è La canzone di Solvejg. È lei la ragazza di cui Peer si è innamorato da giovane e che lo ha aspettato tutta la vita nella sua capanna nel bosco intenta a filare, richiamando così alla mente Penelope che attende Ulisse. Per comporre questo canto d’amore, Grieg ha ripreso la melodia di un’antica ballata medievale norvegese che narra di un amore infelice e l’ha riadattata per cantare la storia d’amore tra Peer e Solvejg. Dopo una breve introduzione degli archi inizia la nostalgica linea del canto in la minore sostenuta sempre dai violini insieme all’arpa, strumento che ci riporta a una dimensione arcaica e quasi sospesa nel tempo. Durante poche battute cambia il carattere della musica: la tonalità modula al maggiore, la speranza è entrata nell’attesa di Solvejg, si ripete poi un’ultima volta la melanconica melodia. L’opera si conclude con il definitivo ritorno di Peer da Solvejg che, ormai avanzata negli anni e priva della vista (è significativo questo, perché lei sa vedere bene col cuore), lo accoglie a braccia aperte ringraziandolo per aver fatto della sua vita un «magnifico canto» e rassicurandolo che lo ha sempre custodito nella propria fede, nella speranza e nell’amore.
Articolo di Felicita Pacini